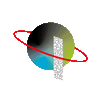Un crepitare d'immagini: pensieri su Civil War e il cinema
Grazie al cielo il cinema d'autore americano sa ancora produrre immagini. Una recensione di Civil War di Alex Garland.

Dopo aver visto Oppenheimer mi ero chiesto se il cinema d'autore americano fosse ancora in grado di produrre immagini. La risposta me l'ha data Alex Garland ed è un sì, convinto.
Per evitare equivoci, chiarisico immediatamente un punto importante: le letture culturali di un film non sono cosa mia, le lascio volentieri fare ad altri o, al massimo, le tengo a margine del ragionamento.
Quindi se da questo post ti aspetti una lettura del modo in cui Civil War affronta uno o più aspetti della cultura contemporanea forse, te lo dico subito, è meglio se chiudi la scheda e passi ad altro.
Se invece vuoi correre il rischio e avventurarti in questa recenzione sappi che quando si parla di cinema sono un formalista. La mia scuola è quella del compagno Sergej Michajlovič Ėjzenštejn.
A me interessano le immagini e un regista ne produce una quando usa in modo verticale tutte le leve che ha a disposizione per dare vita a un concetto visivo.
Questo significa che un immagine non è qualcosa a cui è sempre possibile attribuire un significato o un senso precisi. Al contrario, un'immagine, per me, è un'idea che può essere percepita attraverso i due sensi principali a cui il cinema si rivolge: la vista e l'udito.
Civil War d'immagini crepita e, per quanto mi riguarda, questa non può che essere una buona cosa. Di sicuro è abbastanza per riconciliarmi con il cinema d'autore americano. Per me, che sono figlio della guerra fredda e della televisione commerciale, è certamente una buona notizia.
Alcune note ontologiche d'introduzione
Prima di lanciarci attraverso il crepitio d'immagini di cui è fatto è opportuno spendere qualche riga per chiarire cosa Civil War non è: un film di guerra.
Quello di Garland è piuttosto un film sulla nebbia di guerra, ovvero sulla difficoltà di capire come evolve un conflitto quando ti ci trovi immerso dentro. Prima che abbia inizio l'ultima sequenza del film, infatti, la situazione strategica della guerra civile messa in scena dal regista americano è del tutto indecifrabile, tanto per lo spettatore quanto per i suoi protagonisti.
A livello operativo e, soprattutto, tattico, la guerra, sembra volerci dire Garland, non altro che un confuso susseguirsi di episodi apparentemente scollegati tra loro, il cui esito è tutto tranne che lineare e, a volte, può addirittura essere contraddittorio.
Una vittoria tattica localizzata potrebbe non avere alcuna rilevanza a livello operativo o strategico, per quanto esaltante possa apparire a chi ne è coinvolto e la consegue.
Se negli ultimi due anni ti sei mai chiesto chi stia davvero vincendo in Ucraina questa è una dimensione con cui ti conviene cominciare a familiarizzare al più presto, perché ogni guerra acquisisce chiarezza solo quando può essere analizzata con il distacco e la freddezza dello storico.
Prima di quel momento, i contorni dei fatti sono incerti e le forme con cui essi si presentano contraddittorie e ineffabili.
I protagonisti del film, un gruppo di giornalisti in viaggio attraverso gli Stati Uniti sconvolti dal conflitto, ne sembrano al tempo stesso consapevoli e ignari.
A muoverli, infatti, non sembra tanto la volontà di capire chi stia vincendo e chi no quanto, piuttosto, quella di essere presenti nel momento in cui la Storia prende forma dal caos degli eventi che la determinano, documentando ciò che può accadere nella nebbia da cui emergono.
È attraverso le loro azioni e i loro pensieri che Garland risponde a chi, con l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, si affanna a sostenere che ogni immagine sia ontologicamente in relazione con il falso.
Non che i gatekeeper dell'IA abbiano del tutto torto, ma la risposta che il regista dà loro è che, al di là di ogni capacità di produrre immagini di sintesi, la fotografia non smette di conservare quel valore testimoniale che la sua origine come processo fotochimico le ha consegnato nel corso della storia della nostra cultura visiva.
Se vi è del falso nell'immagine, sembra questa la posizione espressa da Garland, è ai suoi confini che esso s'ammassa per violarli.
Che si tratti di un dettaglio insignificante o della morte colta in azione, al centro dell'immagine c'è e non smette di esserci l'atto di estrarre un istante dallo scorrere implacabile del tempo, per consegnarlo all'eternità dell'interpretazione e del suo infinito gioco di rimandi.
La didascalia che falsificherà l'immagine che affiora progressivamente alla superficie dal liquido di emulsione su cui scorrono i titoli di coda non cambia il fatto che nel suo cuore giace, esanime sul pavimento dello studio ovale, il cadavere del presidente degli Stati Uniti, circondato dal commando che ne ha appena provocato la morte.
Sapere in che modo quell'immagine verrà piegata dalla narrazione degli eventi non conta. Ciò che importa è la presenza di chi l'ha prodotta sul luogo in cui quell'evento si è verificato. La dimensione irriducibile del reale, che supera tutte le sovrastrutture sociali per darsi come pure potenza dei sensi.
Una potenza violenta come la guerra, ne cui strati Civil war, che in ultima istanza è un road movie sul giornalismo di guerra e sulla fotografia, fa precipitare lo spettatore mano a mano che la vicenda procede.
Dallo sprofondare nella violenza dei civili in armi fino all'implacabile e robotica precisione delle truppe regolari nell'urban warfare che chiude la narrazione, quella che Garland espone nel suo film è una teoria del divenire guerra del corpo sociale.
Passando attraverso i suoi concatenamenti, lo spettatore impara a conoscerla e, attraverso le immagini viene a contatto con essa. Eppure, come il fotografo che usa la macchina fotografica come schermo per allontanare se stesso dalla realtà che ha di fronte, chi vede Civil War occupa sempre un posto estraneo all'azione. Vi assiste ma non vi partecipa, in aperta contraddizione con la qualità immersiva che caratterizza i prodotti egemonici del mediascape contemporaneo.
Strana ambiguità dell'immagine, che testimonia del reale e, testimoniandolo, ci distanzia da esso al punto da plastico e malleabile fino all'estremo della falsificazione.
Anticlimax. Anticlimax ovunque.
Posso solo immaginare come Jean Baudrillard avrebbe potuto commentare questa nostra epoca in cui la costruzione di simulacri si è spinta a un tale livello quantitativo da aver reso il worldbuilding l'atto fondativo di ogni manifestazione mediatica.
La moltiplicazione delle realtà possibili, il proliferare di mondi, lo spalancarsi di simulazioni che, come gorghi, ci trascinano nelle profondità di narrazioni al tal punto complesse da occupare interamente lo spettro del sensibile sembra ormai essere la dimensione che occupiamo abitualmente.
Di fronte a essa, Garland sceglie la strada del rifiuto.
Lo fa attraverso la gestione della camera che, come abbiamo visto poco fa, mantiene lo spettatore a distanza dagli eventi, impedendone l'identificazione con le parti in causa nel conflitto e assegnandogli il ruolo di testimone degli eventi.
Lo fa anche attraverso la colonna sonora e, più precisamente, attraverso quello del repertorio di pezzi pop che ne fanno parte.
Quando intervengono a punteggiare la trama delle immagini, le canzoni scelte per la colonna sonora di Civil War lo fanno sempre con una qualità anticlimatica. Non parlano al cervello rettle dello spettatore, non gli impongono che emozione provare ma, al contrario, sottolineano la dissonanza con le immagini che devono accompagnare o si sostituiscono ai loro suoni con effetti stranianti.
L'anticlimax musicale come rifiuto dell'immersività. Piccole crepe, fratture nel flusso incessante del visivo, che aprono spazi in cui lo spettatore può collocarsi per osservare come si producono le immagini, libero dalla dittatura dell'emozione obbligata.
Ancora una volta, il cinema e le sue potenze trovano modo di dispiegarsi.

La guerra è una questione cromatica.
Primissimo piano di un annaffiatoio automatico. Perché lo sfondo è un campo violetto violentemente saturo?
Stacco.
Le strisce di una bandiera americana ondeggiano placide al soffio di una brezza leggera, solo in parte velate dalle foglie di un ramo dai tiepidi riflessi aranciati.
Stacco.
Inquadratura larga. Il suv sui cui viaggiano i protagonisti entra in un ordinatissimo paese delle provincia americana, passando accanto a due cespugli dai fiori viola davanti a cui ricnosciamo l'annaffiatoio automatico della prima inquadratura.
La guerra civile che imperversa nel paese non sembra aver turbato in alcun modo la routine di quel luogo. "Abbiamo oltrepassato un portale spazio temporale?", si domanda uno dei personaggi, passando accanto a quelle deflagrazioni di colore.
Non è così e l'apparenza, scoprirà lo spettatore dopo qualche scena, inganna.
La guerra incombe anche sulla veglia di quella cittadina dove il tempo sembrava essersi fermato. Una guerra che, per Alex Garland, è una questione cromatica.
Il colore la accompagna, comparendo ovunque ve ne siano i segni.
Alla fine della prima azione a cui prende parte Jesse, quella in cui il commando di boogaloo irrompe nel palazzo per liberarlo, contro il muro a cui si appoggia per rifiatare la giovane fotografa che sta imparando la dure realtà del mestiere a cui ambisce campeggiano tre macchie di colore: viola, verde e azzurro.
Torneranno anche più avanti, tra i graffiti dello stadio che ospita i profughi, a farci sospettare che quelle gradinate siano state testimoni di un massacro ormai passato e, un'altra volta ancora, nelle ciocche di capelli del soldato e sulle unghie del cecchino che stanno cercando di eliminare il tiratore scelto che li bersaglia da una grande casa persa nella campagna americana.
La guerra si esprime attraverso il colore e il suo uso. Ecco un'immagine. Ecco un'idea.
Non m'importa se viola, verde e azzurro abbiano o meno un senso, un significato. Non è questo il punto, è la loro presenza e il loro utilizzo che conta.
Ancora un esempio. È un soldato o è un boogaloo quello che sorveglia la fossa comune?
Non indossa la camicia hawaiana, bensì una divisa regolare, ma la plastica di cui sono fatti i suoi occhiali da sole è una macchia di arancione super saturo al centro della faccia e rima con il marrone venato di sangue della terra appena smossa.
Più lo spettro è fluido, più i lupi, le creature del collasso, vero o percepito, escono dall’ombra ed ecco che il trailer come i meme erano ingannevoli, un inganno necessario. Da qualche parte nella campagna ordinata uomini in uniforme ma senza gradi o identificativi fanno quello che hanno occasione di fare. Il loro capo chiede what kind of american are you. Gli schieramenti, le opinioni su Costituzione, doveri, giuramenti, la politica non c’entrano e spettatori e spettatrici perdono un po’ di tempo nell’orientarsi in quello che è il vero colpo di scena del thriller. Le prede sono in un altro piano culturale, i predatori sono tali in un loro estremo della verità biopolitica: non sono interessati alle opinioni, vogliono sapere il continente, l’etnia prossima, la razza. Il colore della pelle non è una realtà chiara ma quegli uomini vogliono giustiziare, riempire le fosse, per il fenotipo. Quelli stanno svolgendo la propria guerra, razziale, forse ancillare, ausiliaria, opportunista a quella del presidente. È ancora possibile nutrirsi e fare benzina ma il collasso è uno stato mentale, un’idea del futuro e se ci sia un futuro. Per gli uomini che riempiono la fosse la guerra etnica è stata ogni giorno per molti anni, la guerra civile l’occasione come l’ignavia della comunità lo è per lo stupratore.
Ancora una volta, è con una macchia di colore che, improvvisa e violenta, esplode la "verità biopolitica" della guerra che riduce ogni relazione al grado zero dell'opzione binaria tra la vita e la morte.
Di nuovo, un'immagine. Un'idea. Un'idea che ci interroga con forza, rivolgendoci una domanda: nel ciclo schmittiano di policrisi in cui ci troviamo a vivere ci sarà la guerra ad attenderci nel futuro che ci aspetta?
Una domanda che evoca presagi cupi e a cui Garland non sembra voler dare alcuna risposta. Ma non è compito dell'arte risolvere i quesiti di una società che attraversa l'ora più scura della notte verso un domani incerto, di cui ancora non si scorgono i contorni.
A essa spetta il compito di aiutarci a percorrere il cammino, producendo idee nuove che squarciano il buio come una raffica di traccianti che ci attraversa lo sguardo col suo assordante crepitio.
Immagini, è di questo abbiamo bisogno. Di immagini e poco altro.
💎 Fermati un attimo! 💎
Ti piace leggere quello che scrivo e pensi che le cose che faccio siano importanti? Con una piccola donazione puoi aiutarmi a continuare in modo libero e indipendente.
Fai una donazione